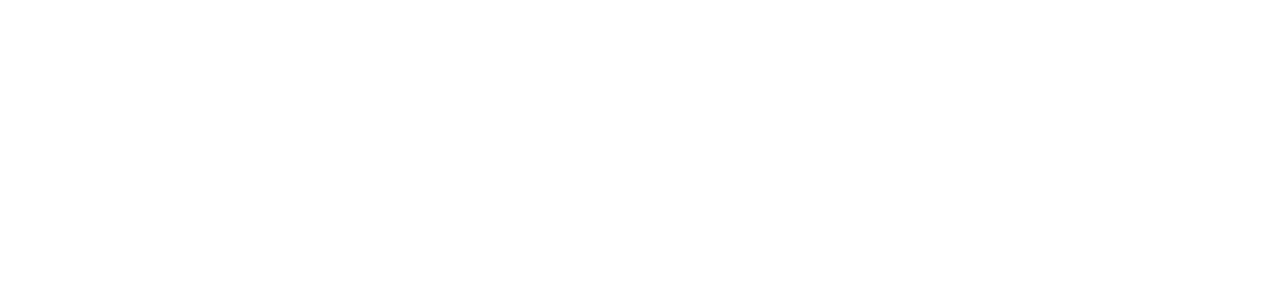GENESI RITROVATE
Proprio mentre eravamo nella jaima di Brahim Maguey nella wylaya di Auserd, (Tindouf, Algeria), Mauro mi ricorda che già nel 2009, a seguito della nostra prima esperienza nei campi con l’ass. Yoda, avevamo organizzato un incontro nella Libreria Idrusa di Alessano per presentare nel Capo di Leuca la strampalata situazione dei rifugiati Saharawi e il disagio della disabilità all’interno dei campi profughi del deserto. Quasi stavo rimuovendo quell’esperienza. Sia io che i miei amici avevamo appena finito l’Università e non volevamo solo trattare i soliti temi dell’illegittimità dell’occupazione marocchina, delle torture, del muro di mine e dei giochi geopolitici che hanno costretto i Saharawi a quarant’anni di esilio nel deserto con la beffa del referendum e l’inesorabile dipendenza dagli aiuti umanitari. Come quando si scava nei conflitti della colonizzazione, le faccende diventano complesse e sconfortanti e rischiavano di spaventare i salentini che in quel momento “imparavano a conoscere i Saharawi”. Volevamo dare un taglio diverso e, allo stesso tempo, scendere più a fondo, parlare dei problemi quotidiani dei rifugiati, della cultura e della psicologia di un popolo dall’identità rarefatta a causa dell’assenza del paesaggio e delle sue risorse, dell’impossibilità di coltivare la propria terra e le proprie passioni in un limbo in cui resistere nella precarietà è l’imperativo e usare il cemento al posto della sabbia è già un segno di resa, come dire di aver accettato di stabilirsi nel deserto anziché lottare per il ritorno nel Sahara Occidentale.
C’era in noi la consapevolezza che creare connessioni tra persone e territori avrebbe aiutato a superare i pregiudizi e la logica della mera beneficienza ma non avevamo ancora messo le mani in pasta. I bambini disabili del progetto di accoglienza sarebbero arrivati in Salento solo dopo qualche tempo ma già in quell’occasione avevamo anticipato le pratiche musicali invitando Francois Cambuzat, un musicista francese nato in Cambogia con sangue algerino, un caro amico che da anni sperimenta gli incastri tra graffianti chitarre noise e i tempi e scale dell’altra sponda del Mediterraneo. Insomma Mauro mi aiuta a ricordare che sono ormai molti anni che creiamo occasioni di confronto tra persone sul piano umano, sociale e musicale minando le sicurezze culturali per entrare nel terreno minato della diversità.

Sono passati sette anni da quell’esperienza, abbiamo ospitato circa 25 bambini, molti di loro hanno subito operazioni e trattamenti sanitari in Italia restando ospiti nelle nostre famiglie. Contemporaneamente ci siamo appassionati alla cultura dei figli delle nuvole interagendo con molti musicisti tra cui Mariem Hassan, Aziza Brahim, Mahmoud Barah e tanti altri. Oggi siamo nei campi profughi con una missione coordinata direttamente da noi insieme a un gruppo di medici, musicisti e volontari dalla Puglia, a occuparci di progetti sanitari e musicali. Con noi c’è proprio Mauro, il medico che all’epoca della libreria era un semplice spettatore insieme ad altri collaboratori che in questi anni hanno creduto nel progetto e nella modalità trasversale di cooperazione e scambio culturale. Nel tempo quella che era solo un’intuizione si è affermata come una strategia vincente nel settore: la cooperazione non può più essere unilaterale, è una relazione, un cambiamento reciproco e “i cooperanti devono essere animatori del proprio territorio oltre che esploratori e facilitatori in quello altrui” (M. Nardelli).
CASA MAGALLANA
Brahim anche detto “Magallano”, la chitarra ritmica del disco, ci ospita nella sua tenda e ci spiega che si tratta di uno spazio provvisorio perché lui, come si direbbe nel mio paese, “si sta sistemando”, ha messo su famiglia con Rabab e la piccola Aisha e si è “alzato le case” e cioè ha ampliato la casetta di sabbia che si trovava vicino alla jaima (tenda) della famiglia della moglie come fanno per tradizione le coppie appena dopo il matrimonio.

Brahim ha un lavoro autonomo, è riuscito a crearsi un mercato offrendo servizi musicali più vari, dj o band dal vivo per la boda (la festa matrimoniale), la fornitura dell’amplificazione per conferenze, concerti ed eventi pubblici e inoltre ormai fa parte dei nostri collaboratori stabili svolgendo il doppio ruolo di accompagnatore dei bambini e di musicista nella nostra band. Ci chiede di Tricase e degli amici della “esquina caliente”, l’angolo che al Villaggio Arcobaleno avevamo dedicato al thè e alle chiacchiere notturne. Sono particolarmente elettrizzato dal suo mondo, lui è un ottimo ponte che mi permetterà di capire da vicino come e quale musica ascolta e balla la gente. Prima di arrivare alla musica però, bisogna pensare agli speakers. Sono davvero malridotti ma, pensando alle notti passate ad ascoltare le registrazioni casalinghe dei Saharawi e dei Mauritani, realizzo che i tweeter sfondati e la voce costantemente in picco sono parte del desert sound che in alta fedeltà risulterebbe sicuramente più freddo e meno sofferto. Ad ogni modo, con accrocchi e saldature improbabili, montiamo i nuovi tweeter che gli ho portato dall’Italia. Mi spiega che gli si bruciano sempre e lui vuole comprarne una grande fornitura in Europa così può sostituirli tutte le volte. Gli faccio presente che sarebbe meglio avere un impianto in cui la potenza di amplificazione è bilanciata a quella delle casse, usarlo nei limiti dei db e si evita di sostituire i tweeter ogni due settimane. Mi guarda con una espressione come a dire “ Lo so! Hai ragione ma magari si potesse fare così, qui funziona diversamente!”. Ecco che si presenta ancora una volta l’aspetto più critico per chi coopera in contesti di precarietà ed emergenza: la difficoltà nel fornire continuità, manutenzione, costanza e l’adeguata attenzione alle azioni, agli strumenti e alle persone.
Brahim mi piace perché è uno dei pochi Saharawi a riconoscere anche i limiti del suo popolo e ironicamente mi dice con il suo spagnolo cubano “Aquì todos son maestros! … Basta che compri una macchina e sei meccanico, basta avere delle casse per essere fonico. Noi siamo così, smontiamo le cose e facciamo esperimenti per farle funzionare alla meglio”. Mi viene in mente l’atteggiamento che io avevo da bambino: quando non funzionava un giocattolo o un apparecchio elettrico, lo aprivo anche se non ne capivo assolutamente niente e cercavo di accrocchiare una soluzione immediata seppur precaria e difettosa. Le sue vecchie JBL sono sopravvissute all’alluvione di ottobre ma, a giudicare dalla sabbia da cui sono ricoperte sembrano aver vissuto gli anni del grande esodo in cui migliaia di Saharawi sono stati costretti a percorrere circa 2000 km a piedi o a bordo dei dromedari per rifugiarsi nel deserto dell’hammada a seguito dell’invasione marocchina avvenuta a suon di napalm. Le cose e le persone nel deserto invecchiano prima perché sono costantemente esposte al sole e al caldo e a un continuo processo di sabbiatura dovuto al forte vento, senza parlare della scarsa attività fisica e del loro costume di sedersi, mangiare e vivere praticamente per terra.
Ascoltando Brahim mentre parla con i suoi amici, mi accorgo di comprendere molte più parole di quanto pensassi pur non avendo mai studiato l’arabo. Nella fluidità del discorso, noto che molte espressioni spagnole si amalgamano con l’Hassanya, il dialetto arabo parlato dai Saharawi e dalle popolazioni berbere della Mauritania. Il caso di Brahim è comune a molti Saharawi che, grazie a un accordo tra i governi, hanno studiato per anni a Cuba nella prospettiva di rappresentare la nuova classe dirigente del popolo del deserto. Ritornando nei campi, i “cubarawi” hanno portato con loro un po’ di lingua e di cultura cubana, che si impasta con le tradizioni dell’hammada. Quarant’anni di isolamento, di rimesse economiche e culturali degli emigranti, di accoglienze e di studio all’estero, di aiuti umanitari e di cooperazione hanno portato alla formazione di una lingua ibrida in cui si mischiano l’arabo, i dialetti berberi, il catalano e il cubano, il francese, l’inglese e le parole internazionali che il mercato globale ha inserito ormai in qualsiasi contesto anche quello più sperduto. Ecco che, nella torrenziale musicalità della lingua, riesco a captare parole come naranja (arancia), boutique (negozio), mismo (stesso), internet, windows, coke. Inoltre ciò che mi fa letteralmente eccitare è quando incontro delle curiose connessioni tra l’arabo e il mio dialetto come nel caso della parola maccarruni (la pasta) o della parola “gatto” che in arabo classico sarebbe “qat” ma in Hassanya è perfettamente uguale al dialetto salentino: musc(iu).

Poco dopo ci raggiungono El Ouali, un giovane tastierista che porta il nome del più famoso tra i martiri della causa Saharawi, e Lemrabat, il figlio dello storico cantante cieco Mahfoud Aliyen. Brahim gli ha detto che ho dell’attrezzatura audio e loro vogliono registrare qualche pezzo da presentare per un concorso in Algeria. Ci mettiamo al lavoro: uso il mio provvidenziale handy recorder per allestire un piccolo studio nella jaima di Brahim, senza particolari problemi visto che la tastiera ha già impostati suoni di basso, chitarra e percussioni e a me non resta che settare il segnale della voce acerba di Lemrabat. Dopo questi anni di conoscenza dei musicisti saharawi ho capito che lo scambio con loro non solo ci permette di scoprire un mondo musicale in cui scale, metodi, gusti e tecniche sono differenti dai nostri standard ma ci fa misurare con un approccio esecutivo e performativo diametralmente opposto rispetto al nostro. A una scarsissima conoscenza degli aspetti legati alla tecnologia, ai software, al suono e alla sua qualità, corrisponde una straordinaria capacità di esecuzione e di improvvisazione per cui quando si registra una canzone è quasi sempre “buona la prima”. Un fattore non da poco, considerato il fatto che, in occidente, il rapporto con la musica suonata si fa sempre più distaccato, sono i computer a fare la maggior parte del lavoro in studio come sul palco e il musicista si abitua sempre di più a suonare parti di canzone in maniera separata più che eseguire i brani completi in presa diretta.
Non mi stupisco. Frequento i bambini Saharawi da molto tempo e tutti hanno sempre dimostrato una spiccata attitudine per la musica, la danza e l’estemporaneità soprattutto i bambini speciali. Girando per le wilaya non è raro incontrare gruppetti di bambini che improvvisano percuotendo qualsiasi tipo di cianfrusaglia. Anche in questo viaggio, incontro tanti bambini che cantano e ballano con incredibile maestria nella gestione dell’espressività riuscendo quasi a sospendere il tempo e a conferire grande energia alla loro performance. Tra loro ci sono talenti incredibili come Nasra o come Mullah che, a sette anni, canta e percuote con maestria e trasporto un tavolino di plastica. La pratica musicale è immediata, ha bisogno di consumarsi in restituzioni intense quanto effimere, è il modo più diretto per ingannare l’attesa e svolgere importanti funzioni private e pubbliche: preghiera, rivendicazione, intrattenimento, gioco, cerimonie, trasmissione culturale, consolazione, festa …

El Ouali e Lemrabat cominciano a registrare senza fermarsi più, 18 canzoni tradizionali e moderne senza che ci fosse la necessità di ripeterne nemmeno una. Finiamo tardi nella notte e io mi sentivo un po’ rintronato da tutte quelle progressioni della tastiera e dai quei preset ritmici che, a mio parere, appiattiscono le dinamiche e la sinuosità della loro musica. Come mi spiega l’amico compositore Ali Mohammed, già dagli anni’80 gli strumenti elettrici e digitali hanno preso il posto di quelli tradizionali e questo ha causato una totale rivoluzione nella scena musicale. Ha portato alla creazione del pop Saharawi, alla contaminazione con gli stili internazionali e quindi alla perdita o alla trasformazione di molte peculiarità stilistiche e ritmiche.
Il tema della musica e degli strumenti musicali però, ci può servire a capire come un popolo sradicato dal suo territorio, dal suo paesaggio e dalle sue risorse, rischia di sgretolare la sua cultura e la sua identità oltre alla sua struttura sociale ed economica. Oggi nei campi è molto difficile trovare un tbal (percussione suonata dalle donne), o un tidinit (strumento a corda antenato della chitarra). Quelli che si trovano sono costruiti in Mauritania dove la musica è ancora un elemento vivo e dinamico della società. Mahfoud Azman, uno dei migliori suonatori di tidinit di tutto il Sahara, ci confessa che lui ha imparato a suonare attraverso i video dei mauritani in Tv. Si fa presto a rendersi conto dello squarcio storico di questo popolo che da un momento all’altro ha perso il suo territorio e, di conseguenza, le materie prime e le conoscenze su cui erano basati l’artigianato, la cucina e le altre espressioni peculiari della sua cultura. Immaginate un Salento senza pajare e muretti a secco, senza frise e grano, senza ulivi e olio, senza artigiani e senza mare … avremmo ancora la tenacia di viverlo? il coraggio di produrre cartoline? la forza di cantare la pizzica?
Ai Saharawi va dato il grande merito di aver lottato in tutti questi anni per conservare e divulgare la loro cultura come elemento di rivendicazione identitaria e politica nel mondo. Lo sfilacciamento della propria identità, condizione caratteristica dello stato del rifugiato, ha generato una perdita di prospettiva, di fiducia e di visione del futuro tanto da riuscire a considerare solo soluzioni e risultati immediati senza avere la possibilità di sviluppare un progetto di lungo periodo e poterne godere dei frutti. Questi aspetti non sono solo considerazioni antropologiche e culturali ma sono fattori a cui dare grandissima rilevanza nelle strategie di cooperazione e di sostegno. Dal punto di vista medico per esempio si fa molta difficoltà a trasmettere l’importanza di una terapia di medio o lungo periodo che sia farmacologica o riabilitativa proprio perché non se ne possono riscontrare gli effetti immediati mentre hanno grande successo farmaci antidolorifici e antinfiammatori il cui risultato è immediato benché solo palliativo.
Proprio secondo questa logica, i due musicisti El Ouali e Lemrabat, appena finito di suonare, mi chiedono le registrazioni senza riuscire a capire che, per un lavoro fatto bene, io ho bisogno di mixare le tracce, ripulirle effettuare qualche sovrincisione e fare il master. Cerco di spiegare che anche noi alla “vasca” (la vecchia sala prove nella campagna di Tricase) avevamo tentato di fare un disco in 3D (un giorno per comporlo, uno per registrarlo e l’altro per mixarlo) ma si trattava di una battuta. Come tutte le cose, produrre un lavoro musicale ha bisogno di tempo, dedizione e concentrazione. Niente da fare però, il concorso in Algeria non può aspettare e io, ob torto collo, mi sacrifico in una prova estemporanea di mixaggio notturno. Finisco quasi alle tre della notte senza essere soddisfatto del lavoro. Sono stremato ma loro restano sempre accanto a me a preparare il thè e a insegnarmi qualche espressione “sporca” in Hassanya. Ancora una volta aveva vinto la logica dell’emergenza che, da un lato, inibisce le grandi prospettive, dall’altro, ti costringe a usare tutta la tua creatività nella ricerca di soluzioni improvvisate ed estemporanee e a condividere con gli altri un destino che non può essere rimandato.
SOTTO LO STESSO CIELO
Quest’anno la mia personale esperienza nel deserto si è prolungata oltre quella del gruppo dei volontari dell’associazione giunto fino ai campi per mantenere vivo quel canale di scambio e di relazione con i bambini e le famiglie che seguiamo da diversi anni. Avevo bisogno di tempo per capire dall’interno alcune dinamiche sociali e comportamentali dei rifugiati e cercare le persone giuste e intraprendenti da poter coinvolgere.
Per due giorni non sono riuscito a muovermi dal centro di Bol-la a causa di una forte tempesta di sabbia che ostacola anche le attività più semplici. Nonostante il turbante e gli occhiali da sole, il forte scirocco (come lo chiamano qui) è un po’ come la neve Salento: una buona scusa per stare a casa. Ne approfitto per registrare qualche suono ambientale, per finire qualche documento al computer e per giocare a calcio in ginocchia con Mohammed e Matah, due bambini ospiti del centro di fisioterapia di Bol-la che seguono trattamenti specifici in Italia da diversi anni e conoscono perfettamente la lingua e il calcio italiano. Sono contentissimi di giocare con me perché mi diverto a fare una animosa telecronaca delle azioni. Peccato che sono troppo piccoli per conoscere Roberto Baggio. Anche il nome di Del Piero non sembra suscitare grande entusiasmo. Mi chiedo quale fosse il giocatore italiano più rappresentativo del momento e non riesco a darmi una risposta. Finisce che usiamo nomi di fantasia per i calciatori e la squadra.

La mattina del terzo giorno, il vento sembra essersi placato e posso raggiungere la wilaya di Boujdour non prima di aver ricevuto un messaggio whatapp dall’Italia con la notizia di una pioggia rosa e sabbiosa che ha fatto risvegliare la Puglia in una coltre di polvere proveniente dal Sahara. Be! Da qualche parte doveva pur andare tutta la sabbia che si era sollevata in questi giorni! Il clima, il vento, la natura mi dimostrano che non siamo noi uomini i primi a mettere in connessione i territori.
Dalla nostra prospettiva, immaginiamo il deserto come un luogo della mente, in cui l’assenza di un paesaggio strutturato può aiutare la meditazione o qualche pratica indirizzata a riallacciare i rapporti tra il corpo e la mente. Immaginiamo sempre le esperienze esotiche come qualcosa di catartico e suggestivo come fossero delle oasi di verità ed equilibrio nelle quali ricaricarsi per affrontare le ingiustizie e le avversità della routine in ufficio. Debbo dire che trovarsi nel bel mezzo del nulla è una sensazione per lo meno alienante, sapere che intorno a te c’è un mare di sabbia più grande dell’Europa, all’inizio ti fa venire una gran voglia di correre. Poi ti stanchi, ti fermi e contempli la tua piccolezza. Visto così, sembra tutto molto suggestivo, ma basta spostarsi verso ovest per scontrarsi con il muro della vergogna: una barriera di sabbia e di mine costruite in Italia e collocate dal Marocco per impedire il ritorno dei rifugiati. A Est invece si apre l’immensità del deserto, la terra di nessuno al confine tra Algeria, Mali e Mauritania dove i traffici di armi, di droga e di persone si ramificano a bordo di pick up o di camion fantasma.
Ci vuole poco a capire che i campi profughi non sono un posto “zen” indicato per ristabilire il proprio equilibrio con la natura e il creato. Il paesaggio è monotono, l’aria è colma di sabbia, rinsecchisce la pelle e le narici, le mosche si posano con ostinatezza su qualsiasi specchio di pelle scoperto, non ci sono prodotti freschi e genuini da mangiare, quasi tutto il cibo è a lunga conservazione ed è quasi impossibile garantire la catena del freddo. Vita difficile per i salutisti e i vegetariani considerando i larghi consumi di carne, zucchero, sale e coca cola. Il rito del thè rappresenta più una pratica di convivialità che non una vera e propria bevanda, tanto che si arriva a perdere il conto dei bicchieri che si possono bere in un giorno e intanto bisogna stare attenti all’assunzione di quantità esorbitanti di zucchero sotto forme diverse: (aspartame, caramelle, dolcetti e gallette, bibite gassate ai gusti più disparati …). La coscienza ecologica è praticamente inesistente ed è frequente trovare cumuli di rifiuti incendiati che liberano un fumo scuro e puzzolente. La mia mente va alla campagna salentina dove, neanche per me, è raro trovare pneumatici e altri rifiuti in fiamme. Mi viene in mente il “Progetto Urano”, un’indagine partita dalla Puglia che già negli anni’80 svelò lo smaltimento illecito di rifiuti speciali dal sud Italia al Sahara Occidentale. Ferite di un’Italia di mafie e collusioni del governo che si riaprono proprio in questi giorni in cui viene liberato il presunto omicida di Ilaria Alpi. Probabilmente il malaffare internazionale rappresenta una forma di connessione territoriale che, seppur nella sua nefandezza, ha dimostrato di poter cavalcare distanze e culture in modo diretto senza farsi carico di tutte le complicazioni e le formalità del mondo della cooperazione. Me lo dimostra Brahim per il quale, un ora dopo avermi conosciuto, io ero praticamente diventato “El Puccini, l’italiano mafioso”.

Eppure quasi tutti quelli che vengono nei campi, anche attraverso una prima semplice esperienza di volontariato, ci ritornano. Per quasi tutta la gente che si incontra qui, il viaggio nel Sahara rappresenta un appuntamento fisso e periodico, per un motivo o un altro quasi irrinunciabile. Forse sono amanti del silenzio o dello spettacolo del firmamento, forse vogliono assaporare i pinchitos di cammello, partecipare alla Sahara Marathon o fare il record di thè bevuti in un giorno. Credo però che si tratti di rapporti umani, di relazioni con una famiglia, con un bimbo, con un amico che vogliono rivedere e rivivere. O forse del senso di gratificazione per aver fatto qualcosa di buono nel cosiddetto terzo mondo. Per molti anni, i campi Saharawi hanno rappresentato un terreno facile per la cooperazione dal basso, un rapporto di aiuto diretto quasi da persona a persona. Attraverso le associazioni, le accoglienze dei bambini, le politiche di cooperazione decentrata dei comuni e delle province, i Saharawi hanno creato un vero e proprio sistema di ospitalità degli stranieri anche grazie alla loro cultura moderata, nomade e molto ospitale. Un equilibrio che è stato minacciato nel 2011 con il sequestro dell’amica cooperante Rossella Urru, indirizzato a minare la sicurezza degli stranieri nei campi profughi e, a seguito del quale, tutto il sistema di controllo si è fatto decisamente molto più pesante e vincolante. Sappiamo però che, così come la nostra economia, le tensioni scatenate dal terrorismo hanno un raggio globale e la cessione della libertà a favore di una maggiore garanzia di sicurezza sembra essere un diktat che tutto il mondo è costretto e lieto di accettare. È così che, mentre le nostre famiglie sono preoccupate perché noi andiamo in una presunta area calda, le bombe scoppiano a Bruxelles, a Istanbul e Lahore. Il presupposto della nostra azione è dunque quello che non esiste un posto stabile e sicuro contrapposto a uno posto instabile e rischioso. Non ci sono posti ricchi e civili che aiutano unilateralmente le zone del mondo generalmente considerate povere, corrotte e oppresse. Ogni territorio, a tutte le latitudini, ha i suoi limiti e i suoi problemi che vanno riconosciuti, accettati, analizzati nella loro specificità e nelle possibili connessioni con il mondo esterno. Imparare a identificare i propri limiti, sia personali che di comunità, potrebbe essere un punto di partenza per non rimanere sempre nel campo della rappresentazione e della mistificazione, per potersi guardare allo specchio per quello che si è anche con una giusta dose di auto-critica e auto-ironia. Non si tratta di un processo unilaterale che si può affrontare da soli, siamo tutti coinvolti, l’incontro rappresenta l’unica strada verso il riconoscimento reciproco dei propri pregi e dei propri difetti nella consapevolezza di essere parte dello stesso destino.
UNO STUDIO NEL DESERTO
Ho passato diversi giorni nella wilaya di Auserd dove ho lavorato con Brahim per conoscere meglio il suo lavoro. Ho incontrato i musicisti Mahfoud Azman, Mahmoud Bara, Mahfoud Aliyen, Lemrabat Aliyen (figlio di Mahfoud), ho improvvisato con Wadha scoprendo che ogni popolo, a latitudini diverse, ha il suo “Biagino” (animatore di matrimoni ed eventi). Il resto del mio tempo l’ho trascorso nella wilaya di Boujdour, dove la Ong Sandblast sta cercando di riattivare “Studiolive” uno dei progetti più ambiziosi e coraggiosi del deserto: la realizzazione di una sala di registrazione professionale all’interno dei campi. L’obiezione più comune al quale devo spesso rispondere è “Ma a cosa serve uno studio in un contesto di emergenza sanitaria, alimentare e sociale?”. La risposta può intuirla chi conosce un po’ la condizione dei rifugiati. Strappati dalla loro terra, dalla loro cultura basata sostanzialmente sulla trasmissione orale, i Saharawi hanno così la possibilità di registrare, diffondere e archiviare del materiale audio/visivo sulla loro identità (radio, musica, poesia, interviste …). Non è un progetto facile. Nessun progetto è facile in un contesto che ha scarse motivazioni. Sappiamo però che solo quando una esigenza viene percepita anche dalle persone locali, ci sono i margini per cooperare bene e in maniera efficace. Per quanto possano essere belle e complete le nostre analisi di contesto, se questi bisogni non vengono fatti propri dai diretti interessati, i progetti faranno quasi sempre un buco nell’acqua oltre che nelle tasche dei finanziatori. Nel tempo Studiolive ha cambiato diverse location e responsabili, ha subìto furti e perdite di attrezzatura, ha formato giovani fonici, ha creato progetti con il coinvolgimento di bambini e di musicisti. Oggi, a seguito dell’alluvione di ottobre, il progetto ha trovato una nuova location all’interno del Centro Union de Mujeres di Boujdour. La responsabile è una giovane ragazza che parla inglese di nome Shaia. Shaia ha seguito i corsi da tecnico del suono e i corsi di lingua fatti dagli americani cooperanti freelance. Il centro rappresenta un catalizzatore di iniziative perché è un posto sicuro, aperto a tutti, con spazi ampi adatti a effettuare meeting e iniziative. All’interno del centro incontriamo prima di tutto la delegazione delle donne responsabili dell’Unione, una organizzazione nata insieme al Polisario per sostenere le donne e il loro importante ruolo nei campi data l’assenza degli uomini all’epoca impegnati sul fronte. Qui si svolgono i corsi di formazione di molte ong tra cui Oxfam e Medicos del mundo. È il posto giusto per incontrare ragazze e ragazzi che rappresentano la generazione dinamica dei Saharawi ma sicuramente anche quella più fragile e disillusa. Mi convinco quindi che è il luogo adatto a ospitare lo studio che ha bisogno di energie serie e fresche per ripartire.

Il mio compito è quello di aiutare Shaia ad allestire la sala, montare la porta di ingresso, aprire una finestra interna tra la sala di registrazione e quella di regia e preparare il report perché il cooperante della prossima missione sappia cosa portare e come muoversi. Ad aiutarmi Massimo, Belen, Mauro e le maestranze saharawi Boumeddien e Salek.
I lavori mi sembrano venuti bene anche se io sono sempre stato una persona che pretende troppo. Vorrei che tutti i lavori fossero realizzati ad arte, vorrei una società senza malaffare che rispetti l’ambiente e in cui tutti gli uomini mettessero passione nelle cose. Insomma sono un rompicoglioni. Fortuna che basta poco per addolcirmi: un thè, un po’ di fantasie sulla possibilità di portare i miei amici a registrare nel deserto e la consapevolezza che il nostro lavoro possa davvero portare i suoi frutti. A fine giornata mi ricordo dell’intervista che ho fatto qualche anno fa a Rossana Berini, cooperante free-lance che ha scelto di vivere definitivamente nell’Hammada. Nell’intervista Rossana mi confessa che, nonostante le priorità sanitarie, ciò che le fa più paura è la prospettiva dei giovani che vivono ogni giorno senza riuscire a dare risposte per il proprio futuro ed è per questo che la musica, l’arte e la cultura, pur non essendo prioritarie, riescono a superare le necessità del quotidiano, a regalare una visione più ampia capace di proiettarsi positivamente nel mondo.